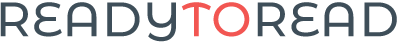Hotel Suite Inn
CE CH’AL VA E CE CH’AL RESTE
di Paola D’Agaro ♦
Il giorno in cui Jacu dai Rais scomparve nel nulla era un giorno come ce ne sono tanti ad Avasinis, piovoso e lento. Rivoli di fango tra le poche baracche rimaste dal post-terremoto, lampadine da 30 candele accese in pieno giorno, fili elettrici sospesi, impalcature sparse, il chiocciare delle galline nei pollai e il trafficare laborioso e usuale delle donne davanti allo spolert1, con la legna troppo umida che non vuol saperne di prendere, neanche con la diavolina.
Ad Avasinis Jacu c’era nato, esattamente trent’anni prima che la terra si mettesse a tremare squassando case e persone nel profondo. Erano le prime ore di una domenica da tregenda, con la tramontana che sčhassonava2 alberi e case e i pinigots3 che scendevano dallo spiovente del tetto, scintillando come spade di cristallo contro il chiaro di luna. La levatrice, svegliata nel mezzo della notte da un gran vociare da ubriachi (il futuro padre non aveva fatto in tempo a smaltire gli eccessi alcolici della sera prima), era scesa di corsa in cortile ficcandosi in testa il berrettone di panno lenci. Ma la bicicletta non voleva saperne di partire, per il gran gelo che aveva ingrippato la catena, così la levatrice a casa di Jacu ci era arrivata col sedere ben piantato in sella alla mula che il capostipite dei Rais, aspirante padre del primo erede maschio dopo la bellezza di sei femmine, guidava con un impegno non proporzionato ai risultati. Quando arrivò, nel togliersi il mantello di ruvida lana militare (l’aveva ricavato da una coperta che qualche partigiano aveva abbandonato davanti al camino dello stavolo di Planecis e c’era voluto del bello e del buono per rammendare i buchi provocati dalle scintille) capì che tutta quella fretta esagerata era stata superflua. Jacu era scivolato fuori senza sforzo dalle floride carni della madre e se ne stava lì, imbozzolato nella sua camicia, a guardare il mondo con il bulbo degli occhi proteso, come un enorme pesce rosso in una boccia di vetro. La solennità con cui la levatrice, non prima di essersi espressa in una serie di gridolini di circostanza, procedette a liberare il bimbo dal sacco amniotico e a tagliare il cordone ombelicale la ripagò ampiamente della levataccia. Mai era stata testimone di un evento simile, e gli sguardi ammirati e vagamente terrorizzati delle donne presenti erano lì a confermarle, se ce ne fosse stato bisogno, l’eccezionalità dell’evento. Di cosa significasse “nascere con la camicia” era riuscita a formarsi una vaga idea solo grazie alla foto, sfocata e in bianco e nero, che corredava l’apposito capitolo del suo nuovissimo “Manuale di ostetricia”.
Quella nascita prodigiosa fu oggetto di un’inarrestabile dialettica che andava serpeggiando tra le case e nelle tre osterie del paese occupando per qualche tempo uno spazio ragguardevole nei discorsi dei giorni feriali. Nonché di quelli festivi, naturalmente. Jacu crebbe circonfuso di un’aura di santità che la madre provvide a riposizionargli addosso con grande impegno, ogni volta che il ricordo si affievoliva, facendogli baciare più volte il brandello di camicia che portava appeso al collo in un minuscolo reliquario e parlandogli di quando i Benandanti, nati come lui con la camicia e divenuti stregoni, combattevano le streghe e le cacciavano dalle stalle insieme alle loro malefatte. Jacu, incoraggiato in questo dalla genitrice rimasta presto vedova, ritenne quanto mai inopportuno portare la sua sacra medaglietta su e giù per le impalcature di mezza Europa, con la cazzuola infilata nella cintola e cinquanta chili di cemento sulle spalle, cosa che si erano rassegnati a fare più o meno tutti gli uomini validi del paese. Nemmeno il corpo degli alpini (orgoglio di tutti i giovani friulani che lasciavano gli affetti domestici al grido di “Alpin jo mame!” per sentirsi rispondere: “Čhastron tu fi!”4 secondo un rituale scaramantico consegnato alla storia) poté contare su di lui. Il suo torace da uccello, gli occhiali spessi un paio di centimetri – senza contare il suo status di unico figlio maschio di madre vedova – fecero sì che fosse spedito dritto dritto all’ospedale militare e da lì a casa della madre con il timbro “RIFORMATO” sul foglio matricolare.
Così, quando la vita di vedran5 coccolato e viziato dall’anziana madre e dalle sorelle – presso le quali andava ospite per il fine settimana seguendo un rigorosissimo ordine anagrafico – cominciò a venirgli a noia, pensò bene di inventarsi un mestiere che facesse al caso suo. Sotto gli occhi ammirati della vecchia, sgomberò il tinello da biciclette, rastrelli, ramazze, vecchi scarponi incrostati, secchi del latte, gerle e ratatujas6 di ogni tipo accumulate negli anni. Poi rinfrescò con la calcina le pareti, spalmò un intero barattolo di colla sul pavimento in seminato veneziano e ci stese sopra del linoleum color cachi, montò un lavandino in ceramica che collegò alla tubatura della cucina e una mensola in vetro su cui avrebbe posizionato l’attrezzatura. Acquistò infine un armadietto di metallo, decisamente sovradimensionato per le tre coppie di asciugamani che andò ad ospitare. Ma il pezzo forte doveva ancora arrivare: una poltrona da barbiere usata, con lo schienale reclinabile e la base girevole. Non faceva nulla per non dimostrare i suoi anni, con i braccioli in similpelle strappati da cui affiorava una gommapiuma grigiastra e lo schienale unto di brillantina, ma il contributo alla causa da parte delle sorelle, seppure condito da un misto di preoccupazione e orgoglio (il tutto si era svolto in gran segreto per non far innervosire i mariti nonché generi) non aveva consentito niente di meglio. Ecco, ora il Jacu aveva un lavoro: barba, capelli, basette, baffi, sfumatura alta e sfumatura bassa… gli sembrava che nulla sarebbe stato più un mistero per lui. Più che l’insegna “BARBIR” penzolante dal parapetto della linda7 poté il passaparola dei compaesani che, prima timidamente poi in maniera sempre più disinvolta, si presentavano nella bottega del Jacu per una sistemata alla zazzera o una regolata al pizzetto. Ben presto, la disinvoltura divenne spavalderia, così poteva capitare che qualche giovanotto, una volta rasato e impomatato a dovere, infilasse la giusta mercede destinata al Jacu nella scatola di “biscotti Bovolone” che fungeva alla bisogna e ne arraffasse il doppio dal gruzzolo lasciato da chi l’aveva preceduto. Tutti sapevano di questa curiosa abitudine, ma nessuno ci faceva caso. Il Jacu aveva imparato il mestiere sul campo, per tentativi ed errori, a colpi di forbice, macchinetta e rasoio, e la disponibilità da parte dei compaesani nel collaborare all’affinamento della tecnica di barbîr e piruchîr8 meritava un compenso. Ma non c’era compenso che uguagliasse quello che, varcata la soglia della čhasa9, lo attendeva ogni mezzogiorno. A dispetto del suo fisico smilzo, il Jacu era un’ottima forchetta e un grande estimatore della polenta, soprattutto se accompagnata dalla frittata filante: formaggio latteria fresco, uova, sale, noce moscata e abbondante pepe. Il numero delle uova (rigorosamente di giornata) era deciso di volta in volta da un Jacu trionfalmente assiso a capo di una tavola ormai vuota ma che un tempo aveva ospitato otto bocche pigolanti (la nona faceva la navetta dal cucinino alla sala da pranzo – nobilmente definita čhasa – e si sedeva solo quando tutti se n’erano andati alle loro faccende). “Trops ûvs vuê, Jacu?”10 era la domanda di rito alla quale il principe di casa rispondeva alzando un numero di dita adeguato all’appetito del momento. Numero che partiva da due e poteva arrivare fino a cinque, l’intera mano.
La tranquilla esistenza di Jacu venne appena scalfita dal terremoto del 1976. Miracolosamente, casa e bottega ressero l’urto e bastò qualche piccolo rinforzo ai muri portanti perché la vita potesse ricominciare come prima.
Insomma, Jacu dai Rais ad Avasinis c’era nato, e da lì, prima di sparire, si muoveva raramente e con una certa riluttanza, tranne che in due occasioni: la festa del formaggio a Mauthen e la sagra di Santa Caterina a Udine.
Quando arrivava il 24 novembre, il Jacu chiudeva bottega, ritirava il completo pied-de-poule in lana cotta dal fil di ferro della linda dove era stato messo a svolazzare qualche giorno prima per liberarlo dall’antitarme e, dopo una lunga ed elaborata vestizione, partiva. A completare la visione d’insieme del Jacu che aspetta la corriera che lo porterà fino a Udine sono una vecchia canna da passeggio (la bagulina) e una coppola dalla fodera unta di brillantina dello stesso colore dell’abito. Ma non è tutto. Sulla schiena del Jacu c’è la fisarmonica in celluloide, con i tasti d’avorio e la targhetta in ottone con la scritta “Borgna”, che il padre, grande allietatore di pigri pomeriggi domenicali in osteria, gli ha lasciato in eredità. Insieme allo strumento, l’augusto genitore gli ha trasmesso anche qualche rudimento di tecnica, troppo poca perché il Jacu possa dirsi un fisarmonicista come ce ne sono tanti sparsi per il Friuli e perché egli possa ambire a destare l’interesse e l’ardore di qualche femmina locale, ma sufficiente per non creare troppo fastidio alla fiumana dei visitatori nel chiasso e nel frastuono della grande kermesse udinese.
Jacu e la sua fisarmonica scendevano dal torpedone delle “Autolinee fratelli Olivo” in piazzale delle Corriere da dove, attraverso strade e vicoli, arrivavano in piazza I Maggio, il Zardin Grant, come si chiamava un tempo. Anche al Jacu, come a Renzo Tramaglino nel suo procedere verso Milano e i suoi disordini, qualche indizio di quel che vi avrebbe trovato veniva incontro durante il tragitto: padri sorridenti con i bimbi in spalla che gonfiavano le guance soffiando fiato e saliva su lingue di Menelik e madri che arrancavano qualche passo indietro, con le braccia cariche di pacchi; bastoncini di legno con qualche residuo di zucchero filato; volantini che strillavano, a suon di maiuscole e di punti esclamativi, la presenza serale di orchestrine di liscio. Ma prima di tuffarsi nella mischia, il Jacu provvedeva a registrare la sua presenza in via Francesco di Toppo, dove la siore Elvia aveva riservato una camera per lui. Era una cameretta dai muri ruvidi, intonacati di fresco, con travi e tavelle a vista nel soffitto. Si trovava nella mansarda della vecchia casa di famiglia. La siore Elvia aveva preso ad affittarne le stanze al principio degli anni Ottanta e da allora il Jacu non aveva mai smesso di farle visita ogni novembre assistendo a tutte le trasformazioni che avrebbero portato la casa a diventare da b&b una pensione vera e propria. Con la siore Elvia scambiava quattro chiacchiere, ruvide come sono di solito le chiacchiere tra friulani, beveva il suo consueto tai di vin11 (quasi sempre rosso, aspro e poco alcolico) poi, rimasto solo, spalancava la finestra e si godeva lo spettacolo delle casette colorate e operose che si affacciavano sul cortile interno, con i loro bei panni stesi e i vasi di geranio sull’acciottolato. Che non sembrava neanche di stare nella grande città. Nel pomeriggio, finalmente, il bagno di folla del Zardin Grant. E quando, a sera tardi, la sarabanda finiva, non restava che fare un salto al vicino Caffè Caucigh, dove il Jacu “faceva amicizia” con gli avventori – e parecchio anche con i fiaschi di buon vino – e si gonfiava d’orgoglio vedendosi riflesso negli specchi antichi alle pareti, lui e la sua fisarmonica.
Bello viverlo, quel bagno di folla, ma ancor più bello riviverlo, tornato in paese: “Ves di jodi ce roba!”12. E via a raccontare di bambini che volano nei seggiolini appesi alle catene, di uomini grandi e grossi che sparano nei Tiro a segno o che pescano pesciolini rossi dentro alle bocce di vetro, e della gran confusione di gente dappertutto. “E domo baracons, casots, bancuts e catans”13. Ci sono quelli che diventano matti per vendere: “A montin sun t’un scagn e a trombonin, a berlin e a begherin como sacraboltâts cul čhapiel di una banda”14. Finito di raccontare, il Jacu mostrava ai clienti il “bottino” con cui aveva ripreso la corriera per Avasinis. Ogni anno se ne tornava con qualcosa di nuovo: un pennello da barba in setole di puro tasso, una macchinetta per capelli elettrica marchio Philips, un set di rasoi usa e getta e due lame, ma anche una radiolina a pile della Brionvega che non avrebbe mai più smesso di gracchiare dalla mensola più alta della butega15.
Ma quell’anno – era il 1988 – il Jacu non tornò. A casa la madre lo aspettò invano, con le uova già in fila sulla tavola, pronta a chiedergli quante ne richiedesse la sua fame. Nessuno lo aveva visto salire in corriera e la siore Elvia, interrogata in proposito dal maresciallo che aveva accolto la denuncia di scomparsa, aveva dichiarato di non averlo più visto dalla sera prima della prevista partenza. Era salita la mattina di buonora per riconsegnargli, spazzolate e lucidate, le scarpe che la sera precedente aveva prelevato fuori dalla porta, com’era solita fare in base a un tacito accordo in vigore da anni. Aveva bussato più volte, prima di decidersi ad aprire, e aveva trovato il letto intatto e la stanza vuota. Ah, sì, una cosa l’aveva trovata: sul comodino c’era una strana medaglietta, una specie di minuscola conchiglia a due valve che ad aprirla ci trovavi dentro un pezzettino di qualcosa che sembrava una grossa caccola di naso, ma altro non era in grado di dire.
Baracconi e bancarelle erano ormai stati smantellati, così il maresciallo fece un salto al Caffè Caucigh, ma anche lì era peggio che andar di notte: nessuno che avesse visto quel tipo un po’ strambo con la fisarmonica, non nei giorni successivi alla scomparsa, almeno. E niente, non c’era verso di venirne a capo. Quello se n’era andato chissà dove con la sua bagulina e la sua coppola. Era cresimato e vaccinato, e che se ne andasse pure al diavolo senza far perdere altro tempo alla gente che c’ha da fare! Questo pensava il maresciallo mentre liquidava i familiari in ansia scesi fino a Udine per capire a che punto stessero le indagini con un: “Siate fiduciose. Stiamo indagando atrecentosessantagradi e abbiamo motivo di pensare che il vostro congiunto stia bene, vi faremo sapere”. Le sorelle si scambiarono uno sguardo tra l’affranto e il fiducioso, aprirono la bocca per dire qualcosa ma, siccome non sapevano bene cosa, se ne uscirono scuotendo la testa.
L’anno dopo ancora niente, anche se le sorelle le avevano tentate tutte, sottoponendosi persino al supplizio di Chi l’ha visto: tutte e sei schierate in cucina, rigide come stoccafissi sotto gli occhi di milioni di spettatori, il tavolo sormontato dal centrino all’uncinetto davanti e le luci dei riflettori sparati sugli occhi, a rispondere “sì”, “no” alle domande della Raffai. Che se un friulano arriva a tanto, be’ vuol dire che è proprio amore, quello.
Passarono gli anni e il Jacu non si trovava, finché qualcosa venne a turbare le notti delle sorelle ormai avviate lungo quel tunnel che porta alla badante o, in alternativa, alla casa di riposo. Il Jacu di Mulinar, di ritorno dall’“Antica Fiera del Soco” a Grisignano di Zocco, giurava di averlo visto entrare in una roulotte parcheggiata all’interno dell’area dove si erano accampati i giostrai del luna park allestito per l’occasione. Si era pure appostato dietro a un cespuglio in attesa che uscisse, perché di bussare si vergognava, e anche perché con i giostrai non si sa mai. Ma poi si era fatto tardi e aveva dovuto correre a prendere la corriera per tornare a casa. Le sorelle erano troppo vecchie per scendere fino a Grisignano e i nipoti, interpellati, dissero che la fiera era finita, le giostre ripartite e che sul Jacu non c’era da fare troppo affidamento.
Fu così che il barbiere della fiorente comunità dei giostrai sinti fu sottratto al richiamo delle radici (chiamansi più banalmente sorelle) e al pubblico ludibrio. Nessuno seppe mai come il Jacu fosse finito a esercitare il suo mestiere di barbîr e piruchîr tra camper e roulotte. E che ci fosse di mezzo una donna pochi l’avrebbero creduto vero, del resto. Ma era stata proprio una donna, quella femmina prodigiosa che ammiccava da dentro il baraccone del tiro a segno a segnare per sempre la vita del Jacu. “Vuoi provare?” gli aveva sussurrato suadente porgendogli la carabina ad aria compressa e muovendo maliziosa la lingua tra i denti. Il Jacu non aveva azzeccato un solo barilozzo, ma aveva colpito definitivamente il cuore della florida giostraia. E quando questa, dopo una serie interminabile di tiri a vuoto, gli aveva porto con un sorriso una foca di peluche alta mezzo metro (si trattava del premio più ambito, destinato ai soli campioni) lo stordimento dell’uomo era giunto al culmine. Si sposarono dopo tre mesi (rito sinti, beninteso). Certo, fa uno strano effetto vederli ora: lui smilzo e segaligno, lei possente e molliccia dai movimenti indolenti che lasciano intravedere un passato fiorente (aveva infatti esercitato per molti anni il nobile mestiere di donna cannone prima che un repentino dimagrimento, ma soprattutto l’avvento del politically correct, la obbligassero a cambiare lavoro). Mai coppia fu così curiosamente assortita eppure felice, tanto che mai Jacu fu sfiorato da un rimpianto, mai ebbe a sospirare sul natio borgo selvaggio così bruscamente abbandonato.
Ma un mattino – stava per cominciare la sagra di Santa Caterina, pioveva e i baracconi e le giostre sonnecchiavano sotto i teloni grigi in attesa della bagarre serale – qualcosa venne a rimescolare la placida monotonia di una domenica di novembre e nell’animo di Jacu avvenne qualcosa di inaspettato. Da qualche anno il luna park si era spostato in un’area lontana dalla città e dalla fiera vera e propria. “Andiamo, ti porto a Udine”, disse allora Jacu alla sua donna che, sbuffando e sistemandosi il toupè, mollò il giornaletto che stava leggendo distesa sull’enorme letto che aperto occupava l’intera roulotte, e lo seguì. Scesi dall’autobus, zigzagarono tra alti casermoni e arrivarono davanti a un edificio dove Jacu si fermò. Un balcone con un lungo parapetto in ferro battuto ed uno più piccolo ingentilivano la facciata dipinta di un blu carta da zucchero. Ai balconi erano fissate le aste di una decina di bandiere multicolori che garrivano al vento autunnale. Sopra la porta luccicava un’insegna luminosa: “Suite Inn Hotel”. Nel viso di Jacu si leggeva un misto di delusione e di nostalgia. La sua donna lo guardava senza dire niente.
“Andiamo”, disse Jacu. Fu in quel momento che la siore Elda uscì. Era infagottata in un lungo soprabito marrone e seminascosta dall’ombrello ma Jacu la riconobbe subito. Gli anni non l’avevo cambiata poi molto. Lei si ritrovò la coppia davanti, dall’altra parte della strada, e li guardò incuriosita senza riconoscerli. Jacu avrebbe voluto andarle incontro, salutarla, chiederle com’era stato che l’affittacamere di un tempo era oggi padrona di un hotel a tre stelle, ma qualcosa lo trattenne. Pensò che quello che lasciamo resta intatto solo nella nostra testa e che è bene che sia così. Ma è bene anche che il mondo vada avanti, e che i nostri progetti possano compiersi. Era un pensiero semplice, ma un po’ di tempo ci volle perché finisse di srotolarsi nella sua mente e, nel frattempo, la donna se n’era andata. “Allora? Ce ne andiamo o dobbiamo restare qui a guardare le bandiere ancora per molto? Io ho voglia di un gelato”. La voce querimoniosa della moglie lo riscosse. Poi lei appoggiò la testa sul bavero del suo impermeabile stingendolo a sé, lui le cinse le spalle fin dove poté e si incamminarono assieme verso piazza della Libertà e il suo chiasso domenicale.
Note al testo:
- Cucina economica.
- Sčhassonâ = Scuotere con violenza.
- Galaverne.
- Si tratta di uno scambio di battute che mescola l’orgoglio di essere stato arruolato ad un corpo militare “di prestigio” e lo scetticismo affettuoso delle madri. Suona più o meno così: “Alpino io, mamma!”, “Sei troppo stupido, figlio!”. Il Čhastron è il montone.
- Scapolo.
- Ciarpami.
- Ballatoio.
- Barbiere e parrucchiere.
- Casa, ma anche luogo dove si riunisce la famiglia.
- “Quante uova oggi, Giacomo?”
- Bicchiere di vino.
- “Dovete vedere che roba!”
- “E solo baracconi, casotti, bancarelle e ingombri”.
- “Montano su uno sgabello e strombazzano, strillano, urlano come invasati con il berretto di lato”.
- Bottega.