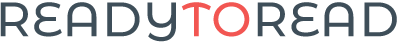Hotel Chaberton CASA
di Francesca Gerla ♦
Resto ferma per qualche secondo sul marciapiede. Guardo di fronte a me, poi in alto, verso le finestre rosse incastonate nel bianco dell’edificio e verso il tetto spiovente incorniciato da due nubi. Sopra, ancora più sopra, il cielo turchese. Sospiro, salgo i tre scalini ed entro nella hall.
Tutto pare esattamente come lo ricordavo; solo, di un altro colore. Abbasso lo sguardo. Il pavimento bianco, la reception in legno, il tappeto rosso con la scritta “Hotel Chaberton”.
Mi sembra sia passato un attimo dall’estate dell’85; mi sembra sia passato un secolo. Sono ancora io?
Mi tocco la guancia, scotta. Qualcuno mi sta chiedendo dove abbia le valigie. Da qualche parte, rispondo. Poi capisco che non riuscirò a sostenere a lungo la finzione, e cerco con lo sguardo la poltrona.
«Tutto bene, signora?»
«È solo l’emozione, grazie».
«Vuole che chiami qualcuno?»
«No, ho bisogno di un attimo… non venivo qui da troppo tempo».
«Ci è già stata?»
«Sì».
Una donna dai capelli rossi e lo sguardo intenso mi sta di fronte. Ho ancora il cappotto addosso, ma fa caldo, qui dentro.
«Perché non si toglie la giacca, così si mette più comoda?»
Non mi muovo. La proprietaria è incerta se insistere. Opta per una soluzione che prenda tempo e vicinanza, senza rischio d’essere invadente.
«Un poco d’acqua?»
«Grazie», annuisco.
Si allontana, e io resto a sfiorarmi l’altra guancia con l’altra mano. Quanto tempo è passato, da quell’estate… Faccio di nuovo il conto degli anni con le dita, incredula. Ero poco più che una bambina, all’epoca, eppure mi sentivo grandissima. Crescevo con l’arroganza di chi si crede già donna solo perché la morte è lontana e non fa paura; non come adesso, che costruisco il mio nido di fragilità con la consapevolezza del mondo e della vita, sempre più corta davanti a me.
Afferro il bracciolo della poltrona con una mano e ringrazio la signora che mi porge l’acqua. Mi piacciono i suoi occhi; mi piace il profumo che si respira qui dentro.
Alzo lo sguardo verso l’ingresso, e sorrido al ricordo di mio fratello che mi faceva le boccacce di nascosto, mentre la nonna ci sgridava per qualche mancanza. Mi pare di vederlo entrare adesso da quella porta, con lo sguardo scanzonato e i capelli in disordine, sempre troppo lunghi o troppo corti. Ha continuato a scherzare come un bambino finché non si è fatto uomo, finché non è morta la nonna e dopo poco zio Teo, finché non ha concluso l’università diventando col tempo quel medico apprezzato che oggi tutti conoscono a Torino.
Era un monello perfetto, Alberto. Sapeva tenerti di buon umore in quelle estati con nostra nonna, la mamma di papà, una donna austera che cercava di aiutare la vedova di suo figlio offrendo lunghe vacanze al mare o in montagna. Quell’anno era capitata la montagna.
Alla notizia della destinazione io, che amavo prendere il sole e giocare a racchettoni sulla spiaggia, avevo sbuffato, mi ero lamentata, avevo protestato. Ma nonna Ida non lasciava molto spazio alle argomentazioni: mi aveva detto “fatti la valigia e basta”.
Così eccoci qui, in questa stessa hall dell’albergo, tutto si illumina di nuovo di colore e mi sembra ieri. Zio Teo, il fratello più piccolo di papà, con lo zaino e le valigie; nonna Ida, che entra ansimando per il troppo caldo; Alberto, che non si stacca dal libro che sta leggendo, Il ritratto di Dorian Gray.
La nonna gli grida di chiuderlo; lui finge di non sentirla.
«Quando è stata nostra cliente, signora?» chiede la proprietaria, che intanto si è presa le valigie e me le ha fatte recapitare nella stanza, al piano di sopra.
«Molti, molti anni fa».
«Adesso si sente meglio?»
Faccio di sì con la testa. Accetto di togliermi il cappotto. Vorrei spiegare a questa signora che negli ultimi anni sono diventata sensibile e nostalgica; che piango per niente, figuriamoci in una situazione come questa. Ma non dico nulla, non sento salire le parole.
«Vuole andare a riposarsi?»
Mi alzo e prendo la chiave, voglio vedere il letto. Immagino non sia lo stesso su cui dormivamo all’epoca; ma la stanza sì. Ho chiesto proprio quella, ed era libera. Divento improvvisamente impaziente: l’attesa davanti all’ascensore mi sembra eterna. Arrivata al piano vedo subito la porta e mi ci dirigo sicura come se ci fossi stata ieri.
Appena dentro la camera, sento un odore familiare, che sembra rimasto uguale in decenni. I miei passi sul pavimento di legno scricchiolano, iniettandomi brividi che dalla pianta dei piedi salgono fino alla fronte. È tutto diverso; è tutto uguale.
Mi stendo sul letto tuffandomici dentro come una bambina. Sembra eterno, il lancio del mio corpo sul materasso. Si alza una nuvola di pensieri e ricordi. Sorrido, mentre chiudo gli occhi.
Alberto, basta con quel libro, ci sono le valigie da sistemare. E vienimi ad aiutare, questa qui è troppo pesante, dove sei finito?
Non voglio guardare l’ora.
So che l’appuntamento è tra poco; ho poco tempo per riprendermi, e cercare di sentirmi di nuovo me stessa.
Vuoi andare dalla nonna? Non smette di urlare. Vuole te, non me. Perché sei più forte, sei uomo tu, no? Come, che c’entra…? Dammi il libro, su, leggi più tardi. Dove scappi? Dammelo!
Resto stesa a guardare il largo quadro sulla mia testa. Montagne innevate. Sento scendere il freddo dalla neve della foto alla parete passando per la spalliera del letto fino alla mia fronte. Trascorro mezz’ora immobile; poi, mi alzo.
In piedi, vado verso la valigia. La apro. Si spalanca sul mio ordine, che a volte mi infastidisce.
In alto a tutto ho sistemato i vestiti per l’incontro. Li ho scelti con grande cura. Vestiti sportivi, ma giusti.
Mi spoglio. Vado in bagno a rinfrescarmi. Prendo i trucchi, mi vesto, mi pettino.
Afferro la borsa e mi preparo a uscire. Dopo pochi istanti, sono fuori dalla stanza.
La prima volta che l’ho visto è stato proprio su questo corridoio. Lui usciva dalla sua stanza, io dalla mia. Prego, prego. L’attesa all’ascensore, lui che diceva: “Bella giornata; bisognerebbe pranzare sull’erba”. Io che rispondevo: “È esattamente quello che farò”. Lui che osservava: “Non vedo il necessario”, e io che puntualizzavo: “Ha tutto mia nonna”.
Piacere Paola; piacere Roberto.
Cui era seguito il più raffinato dei sorrisi. Mai visto un sorriso così; né prima né dopo.
Non avevamo perso tempo con i convenevoli. Il giorno dopo eravamo già a passeggio sul far della sera verso la chiesa della Madonna delle Nevi; ci eravamo seduti sui gradini bianchi, e senza fregarcene di chi avrebbe potuto vederci, ci eravamo baciati.
Scendo nella hall. Devo avere uno sguardo trasognato, perché la proprietaria mi chiede nuovamente come sto. «Emozionata» rispondo; ma non spiego nulla.
Fuori nel parcheggio mi attende la mia Panda. Mi ricordo di quella volta che zio Teo cercò di far partire la macchina della nonna, rimasta con la batteria scarica. Uscì il proprietario dell’albergo ad aiutarci con i cavetti; da lontano ci guardava Roberto, con il suo sorriso. Quel giorno avremmo trascorso qualche ora separati.
Apro l’auto con il telecomando, mi ci infilo dentro e sento caldo. Mi apro un po’ la giacca, sistemo la borsa a lato e parto.
Non sono certa di ricordare la strada; ho messo il satellitare. Prosegui dritto, svolta a destra. Mi sento improvvisamente sola, sperduta. Vorrei mio fratello seduto accanto a me, che mi spiega la strada con una cartina in mano, troppo grande e stropicciata. Anzi, vorrei guidasse lui, come capitava spesso quell’estate. Ce ne andavamo in giro con Roberto ed altri amici, a finestrini spalancati a urlare le nostre canzoni.
Arrivo prima del previsto, in anticipo sull’appuntamento. Ma va bene, forse meglio così. Ho il tempo di riprendermi dall’emozione di rivedere certi angoli; di riconoscere alcuni passaggi, pur sentendomene estranea. Ricordo di essermi fermata in questo negozio, una volta. Possibile sia ancora qui? Potrei confondermi; magari non era a Bousson, ma in qualche altro borgo dei paraggi. La magia di questi luoghi non si è esaurita; anzi, mi aggredisce lo stomaco come quand’ero ragazza, e tutto era magnifico.
Trentaquattro anni sono davvero tanti. E se quattro anni fa mia nipote non mi avesse convinto a iscrivermi su Facebook, manco sarei qui. Due mesi fa mi ha contattata lui. Dice di non avermi mai dimenticato, e io gli credo, perché non ho mai dimenticato lui.
Nelle nostre chat ha provato a parlarmi di lui, ma io non gliel’ho consentito. Gli ho detto: se mi vuoi parlare lo fai dal vivo. E lui ha accettato la sfida; è venuto da Milano, oggi, solo per me.
Cammino lungo una stretta via costeggiata da case basse, che si conclude con la chiesa che già vedo in fondo. La prospettiva sembra perfetta, come questa giornata insolitamente calda per la stagione. Roberto non ha foto sue su Facebook, potrei non riconoscerlo; per questo ogni ombra mi fa sobbalzare: potrebbe essere lui. Io invece sono sincera, sui social: posto foto reali della me attuale. Lui certamente mi riconoscerà.
Arrivo al luogo dell’incontro, quello del nostro bacio. Il primo di una lunga serie, durata tutta un’estate. A fine agosto ci eravamo promessi di non lasciarci mai più: io avevo quindici anni, lui venti.
Ancora non si vede, all’orizzonte. Controllo l’orologio: mancano tre minuti all’appuntamento. Il sole è luminoso e la pietra bianca mi acceca. Mi sembra di esserci stata ieri, tra queste mura, sottobraccio alla nonna che rumina qualche lamentazione. Alla fine le volevo bene, nonostante tutto. Se non fosse stato per lei, non avremmo mai fatto vacanza; se non fosse stato per lei, non avrei conosciuto Roberto.
Il portone della chiesa è aperto. Entro. Mi accoglie un’oscurità fresca, un senso di raccoglimento che mi rassicura, anche se mi fa ricordare il funerale di zio Teo, l’idea della sua morte così giovane mi atterrisce. Mi faccio il segno della croce e raggiungo una delle panche, dove mi seggo.
Respiro al pensiero di quella volta sotto l’albero, al tramonto, io e lui soli a giurarci amore eterno nell’orecchio, in un unico sospiro.
L’autunno successivo a quell’estate io e Roberto l’avevamo trascorso telefonandoci appena possibile e scrivendoci ogni settimana. Io ero di Torino, lui di Firenze. Attendevo l’arrivo della posta con ansia, come se ogni lettera mi dovesse svelare un possibile risvolto del mio destino; scrivevo con foga tante pagine, con la mia grafia tonda. Poi un giorno Roberto mi chiamò per avvisarmi che sarebbe giunto a Torino prima di Natale, ricordo ancora la data precisa: il 20 dicembre, dopo l’ultimo esame all’università. Avrebbe pernottato a casa di uno zio: tutto era sistemato, bisognava solo pazientare quei pochi giorni che ci separavano.
Una volta abbassata la cornetta, mi pareva che la testa mi sarebbe esplosa. Tutti i nostri bellissimi ricordi insieme – gli abbracci nei corridoi dell’hotel Chaberton, le colazioni seduti vicini, le albe e i tramonti, le corse nei campi, il profilo dei monti, il sapore dei suoi baci – tutto mi tornava in mente con dolorosa evidenza. Il nostro amore stava per trasferirsi dal sogno alla realtà; dal ricordo di Cesana Torinese coi suoi panorami alle strade eleganti della mia Torino, trasferendosi nella concretezza.
Dopo quella telefonata, smisi di cercarlo e iniziai a negarmi.
Lui continuò per mesi a contattarmi per telefono e per posta, ma io avevo smesso di rispondere. Non so perché lo avessi fatto: il ricordo delle emozioni era insostenibile, accanto alla paura di chiudere la mia vita in un sentimento troppo precoce, che non sapevo gestire. Complici i miei genitori, che avrebbero preferito mi impegnassi di più negli studi, avevo fatto intendere a Roberto che la nostra storia si era conclusa, senza dirglielo mai.
Ed ora, trentaquattro anni dopo, ho accettato di incontrarlo. Seduta su questa panca inizio ad avere freddo. Guardo l’ora: sono passati dieci minuti, devo alzarmi e uscire di nuovo fuori dalla chiesa ad attenderlo. Abbasso lo sguardo verso la borsa, quando qualcuno si siede al mio fianco. Mi giro a guardarlo, e vedo il più raffinato dei sorrisi.
«Ciao».
«Ciao».
«Non sei cambiata tanto in questi anni: sei sempre bellissima».
«Tu invece sei cambiato».
«Lo so. Sono più bello».
Ci guardiamo e sorridiamo.
«Usciamo di qui?» propone lui. Quando ci alziamo, mi sembra altissimo; non lo ricordavo così.
Percorriamo i metri che ci separano dalla luce osservando il silenzio.
Una volta fuori, l’aria di montagna è riscaldata dal sole.
Lui si gira a guardarmi. Ha la stessa espressione svampita eppure furba di un tempo. Tra le rughe conserva ancora qualcosa del ragazzo che mi sfidava a inseguirlo nei boschi, a rubargli il panino, a baciarlo fino a perdere il fiato.
Mi sorride di nuovo, e mi abbraccia. Il suo abbraccio sembra durare un’eternità e tornare indietro nel tempo, sconfiggendo delusioni, sospiri, rancori, attese.
«Non ce l’hai con me?» gli sussurro nell’orecchio.
«Poi mi spiegherai» mi risponde lui. «Mi racconterai cosa accadde a quella giovane donna che decise, senza motivo, di dare un taglio così netto al nostro amore. Non qui però».
Si è staccato, mi ha afferrato la mano per trascinarmi altrove.
«Dove sennò?»
«Vieni Paola, andiamo a casa. E casa nostra è solo una: andiamo all’hotel Chaberton».